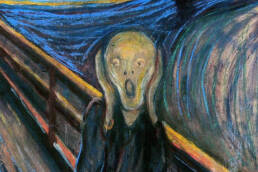Una tavolozza di pigmenti antichi e saperi sorprendenti
Gli affreschi di Pompei ci incantano da secoli, ma oggi – grazie alla scienza – possiamo finalmente comprenderli anche nella loro dimensione più nascosta: quella chimica. Un recente studio condotto dal Parco Archeologico di Pompei, in collaborazione con l’Università del Sannio e l’Università Federico II di Napoli, ha rivelato con precisione la composizione chimico-mineralogica dei pigmenti utilizzati nelle decorazioni murali tra il III sec. a.C. e il 79 d.C.
Tecniche avanzate, approccio non invasivo
Utilizzando spettroscopia e microscopia, i ricercatori hanno analizzato i pigmenti senza comprometterne l’integrità. Questo ha permesso di risalire alla raffinata tecnica pittorica dei Romani, in grado di mescolare con precisione pigmenti naturali e sintetici per ottenere sfumature, coprenze e lucentezze specifiche.
I protagonisti della tavolozza pompeiana
Dall’azzurro egizio (cuprorivaite) – uno dei primi pigmenti sintetici della storia – al minio, passando per ocre, carboni, verdi terre e composti a base di piombo e arsenico come orpimento e realgar. I pittori regolavano intensità e brillantezza con sapienti dosaggi di materiali coprenti come il bianco di piombo.
Una scoperta inedita ha poi ampliato lo spettro cromatico noto: un nuovo pigmento grigio a base di barite e alunite, mai documentato prima nel contesto mediterraneo. La sua presenza suggerisce l’impiego di materiali più vari e tecniche più articolate di quanto si pensasse.
Dalla chimica al restauro
Questo tipo di analisi non ha solo valore storico. I dati raccolti sono oggi strumenti preziosi per i restauratori del Parco Archeologico, impiegati ad esempio nella conservazione della stanza rossa della Casa del Tiaso e nella recente megalografia dionisiaca. Conoscere la composizione dei pigmenti significa intervenire con maggiore accuratezza e rispetto delle superfici.
Un modello per lo studio futuro
Questo studio conferma come l’integrazione tra chimica, mineralogia e archeologia possa riscrivere la storia dei materiali artistici antichi. E forse anche il nostro modo di interpretare il passato.
La chimica, ancora una volta, ci offre nuove lenti per guardare l’arte.
Ed è proprio attraverso questi “occhi” che Ghiaroni sceglie di raccontarla.
Altri articoli
27/11/2025
Il colore ritrovato di Ri de Pomme: quando la scienza restituisce autenticità all’arte
Nel cuore del Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato si trova…
01/09/2025
L’Urlo di Munch: quando l’arte grida… e la chimica ascolta
Pochi quadri al mondo hanno saputo incarnare un’emozione universale come L’Urlo…
28/07/2025
La chimica nell’Arte:
La Tour Eiffel, un’icona protetta dalla chimica
Ghiaroni è partner ufficiale di Radwag, tra i principali produttori mondiali di…